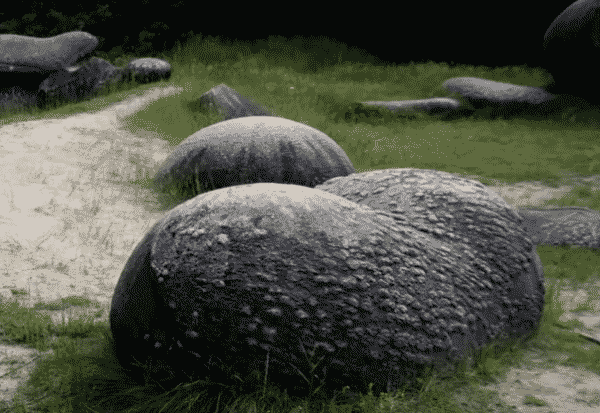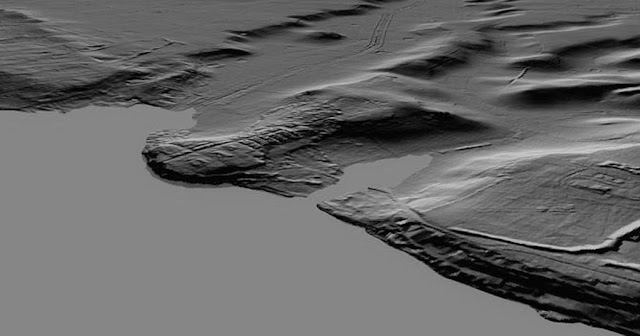Un’enorme statua raffigurante il faraone Ramses II è stata trasferita al «Grande museo egiziano» (Gem) in costruzione nei pressi delle piramidi di Giza, alla periferia ovest del Cairo.
Lo riferisce l’agenzia Mena.
La statua, alta 12 metri, sarà la prima che i visitatori incontreranno nel nuovo museo quando sarà parzialmente aperto al pubblico alla fine di quest’anno.
Questo simulacro, che pesa oltre 80 tonnellate e raffigura Ramses in piedi, ha 3.200 anni ed era stato scoperto nel 1820 dall’esploratore ed egittologo genovese Giovanni Battista Caviglia nel Gran tempio di Ptah, vicino a Menfi.
L’arrivo della statua è stato accompagnato da una fanfara militare alla presenza di varie personalità fra cui vari ministri egiziani. Come noto il nuovo museo «Gem» scavalcherà in grandezza quello delle antichità egizie nella centralissima piazza Tahrir e ospiterà parte del tesoro di Tutankhamon.
La sua prima apertura è stata definita un «importante avvio per il turismo» in Egitto da Rania el-Mashat, la nuova ministra del settore in crisi causa di rivoluzioni e terrorismo.
L’apertura parziale prevede l’esposizione di circa 5.000 oggetti, ha previsto il ministro delle Antichità, Khaled el Anani.
Assieme al questo colosso di Ramses II, all’entrata del museo saranno collocati altri 87 oggetti.
La statua è stata al lungo esposta al centro del Cairo, nella piazza omonima, ed era stata trasferita sul luogo dove sta sorgendo il museo nel 2006.
L’ulteriore spostamento, di circa 400 metri, è durato più o meno un’ora.
Il simulacro non ha nulla a che fare con i pezzi di un altro colosso scoperto al Cairo l’anno scorso e considerato solo in un primo momento raffigurante Ramsete II (si tratterebbe invece di altro faraone meno antico, Psammetico I).
Fonte: lastampa.it