
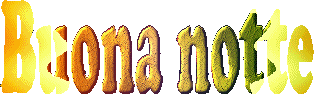
 Il mitreo di Santa Maria Capua Vetere, l’antica Capua, costituisce uno dei rari esempi di luoghi di culto dedicati al dio Mitra con decorazione pittorica, e tra l’altro è anche uno dei meglio conservati.
Rinvenuto casualmente nel 1922, nel corso di alcuni scavi, risale alla fine del II secolo d.C. Dopo una breve scalinata, che scende dal piano stradale al livello sotterraneo, ci si trova in uno stretto corridoio, che doveva fungere da anticamera. Alla propria destra si trova un piccolo ambiente cui si accede attraverso un arco: doveva essere una camera di preparazione (apparitorium) per i partecipanti.
Sulla sinistra, invece, dopo un breve tratto di corridoio, si accede al mitreo vero e proprio, costituito da una lunga camera rettangolare ai cui lati sono addossati dei sedili. Sulla parete di fondo, alla quale è invece addossato l’altare, si trova una splendida decorazione affrescata che rappresenta il dio Mitra nel consueto atto di uccidere il toro (tauroctonia).
In una lunetta della parete orientale si trova rappresentata la Luna su di una biga, mentre in un riquadro della parete meridionale si trova un bassorilievo in marmo con la rappresentazione di Amore e Psiche. Altre pitture sulle pareti laterali, oggi quasi del tutto scomparse, rappresentavano scene di iniziazione dell’adepto, il quale, nudo, veniva accompagnato dai sacerdoti attraverso i vari gradi della sua purificazione.
La volta, dipinta in un fondo giallo, presenta numerose stelle di colore verde e rosso, al centro delle quali si trova della pasta vitrea lucente: alla luce delle fiaccole doveva dare ai partecipanti l’impressione di trovarsi sotto un cielo stellato.
Il mitreo di Santa Maria Capua Vetere, l’antica Capua, costituisce uno dei rari esempi di luoghi di culto dedicati al dio Mitra con decorazione pittorica, e tra l’altro è anche uno dei meglio conservati.
Rinvenuto casualmente nel 1922, nel corso di alcuni scavi, risale alla fine del II secolo d.C. Dopo una breve scalinata, che scende dal piano stradale al livello sotterraneo, ci si trova in uno stretto corridoio, che doveva fungere da anticamera. Alla propria destra si trova un piccolo ambiente cui si accede attraverso un arco: doveva essere una camera di preparazione (apparitorium) per i partecipanti.
Sulla sinistra, invece, dopo un breve tratto di corridoio, si accede al mitreo vero e proprio, costituito da una lunga camera rettangolare ai cui lati sono addossati dei sedili. Sulla parete di fondo, alla quale è invece addossato l’altare, si trova una splendida decorazione affrescata che rappresenta il dio Mitra nel consueto atto di uccidere il toro (tauroctonia).
In una lunetta della parete orientale si trova rappresentata la Luna su di una biga, mentre in un riquadro della parete meridionale si trova un bassorilievo in marmo con la rappresentazione di Amore e Psiche. Altre pitture sulle pareti laterali, oggi quasi del tutto scomparse, rappresentavano scene di iniziazione dell’adepto, il quale, nudo, veniva accompagnato dai sacerdoti attraverso i vari gradi della sua purificazione.
La volta, dipinta in un fondo giallo, presenta numerose stelle di colore verde e rosso, al centro delle quali si trova della pasta vitrea lucente: alla luce delle fiaccole doveva dare ai partecipanti l’impressione di trovarsi sotto un cielo stellato.
 L’affresco policromo della parete di fondo costituisce la caratteristica principale del culto mitraico: la rappresentazione del dio nell’atto di uccidere il toro. Il giovane, che indossa come copricapo il classico berretto frigio, è vestito di rosso bordato di verde, con l’ampio mantello svolazzante dello stesso colore rosso, esternamente, e azzurro, internamente. Si noti, curiosamente, che la Chiesa cristiana utilizzerà lo stesso accostamento cromatico nell’iconografia classica del Cristo.
Sulla sinistra, in alto, un personaggio osserva la scena, ed ha davanti a sé un corvo: è il dio Sole, che per tramite del nero uccello comanda a Mitra di compiere l’impresa. Ai lati della scena, vi sono i due Dadofori, i portatori di fiaccole. Cautes, a sinistra, con la fiaccola sollevata, rappresenta il trionfo della luce sulle tenebre, del giorno sulla notte: è l’Equinozio di Primavera. Cautopates, sulla destra, rappresentato con la fiaccola abbassata, significa invece la predominanza della notte sul giorno, ed è l’Equinozio d’Autunno.
In basso troviamo i tre animali che aiutano il dio nell’impresa: il cane, lo scorpione e il serpente. Si noti quanto risalto sia stato dato soprattutto a questa figura, che si estende per tutta la lunghezza del dipinto, a dispetto delle altre figure. Alle due estremità, troviamo altri due volti, barbuti, che sembrano spuntare dal suolo. L’iconografia ricorda quella del "Genius Loci", lo spirito protettore di un luogo, e tutto l’insieme sembra ricordare un affresco analogo che orna il Mitreo dei Serpenti, presso Ostia Antica.
L’affresco policromo della parete di fondo costituisce la caratteristica principale del culto mitraico: la rappresentazione del dio nell’atto di uccidere il toro. Il giovane, che indossa come copricapo il classico berretto frigio, è vestito di rosso bordato di verde, con l’ampio mantello svolazzante dello stesso colore rosso, esternamente, e azzurro, internamente. Si noti, curiosamente, che la Chiesa cristiana utilizzerà lo stesso accostamento cromatico nell’iconografia classica del Cristo.
Sulla sinistra, in alto, un personaggio osserva la scena, ed ha davanti a sé un corvo: è il dio Sole, che per tramite del nero uccello comanda a Mitra di compiere l’impresa. Ai lati della scena, vi sono i due Dadofori, i portatori di fiaccole. Cautes, a sinistra, con la fiaccola sollevata, rappresenta il trionfo della luce sulle tenebre, del giorno sulla notte: è l’Equinozio di Primavera. Cautopates, sulla destra, rappresentato con la fiaccola abbassata, significa invece la predominanza della notte sul giorno, ed è l’Equinozio d’Autunno.
In basso troviamo i tre animali che aiutano il dio nell’impresa: il cane, lo scorpione e il serpente. Si noti quanto risalto sia stato dato soprattutto a questa figura, che si estende per tutta la lunghezza del dipinto, a dispetto delle altre figure. Alle due estremità, troviamo altri due volti, barbuti, che sembrano spuntare dal suolo. L’iconografia ricorda quella del "Genius Loci", lo spirito protettore di un luogo, e tutto l’insieme sembra ricordare un affresco analogo che orna il Mitreo dei Serpenti, presso Ostia Antica.
 Nella città americana di Cleveland, entra in servizio il primo semaforo stradale elettrico e automatico: ha soltanto due colori, il rosso e il verde.
Nella città americana di Cleveland, entra in servizio il primo semaforo stradale elettrico e automatico: ha soltanto due colori, il rosso e il verde. (© NASA, ESA and the Hubble Heritage Team )
(© NASA, ESA and the Hubble Heritage Team )
 L'abbazia di Casamari venne edificata sulle rovine del municipio romano di Cereatae Marianae, così chiamato perché dedicato alla dea tellurica Cerere e perché residenza di Caio Mario. E proprio da quest'ultimo deriva il nome di Casamari (casa Marii, ovvero, "casa di Mario"). Sorse come fondazione benedettina nel 1035, ad opera di cinque religiosi di Veroli, attratti alla vita monastica dall'esempio di San Domenico di Sora. Ad un primo periodo di rigoglio ed economico seguì una fase di decadenza e di crisi, alla quale sembra abbia concorso lo scisma provocato dall'antipapa Anacleto II. Tra il 1140 ed il 1152 il papa Eugenio III, già monaco dell'Abbazia delle Tre Fontane di Roma, vi introdusse i Cistercensi della linea di Clairvaux, che riedificarono il complesso monastico. Lo steso Papa ne riconsacrò la chiesa il 21 Ottobre 1151.
L'abbazia di Casamari venne edificata sulle rovine del municipio romano di Cereatae Marianae, così chiamato perché dedicato alla dea tellurica Cerere e perché residenza di Caio Mario. E proprio da quest'ultimo deriva il nome di Casamari (casa Marii, ovvero, "casa di Mario"). Sorse come fondazione benedettina nel 1035, ad opera di cinque religiosi di Veroli, attratti alla vita monastica dall'esempio di San Domenico di Sora. Ad un primo periodo di rigoglio ed economico seguì una fase di decadenza e di crisi, alla quale sembra abbia concorso lo scisma provocato dall'antipapa Anacleto II. Tra il 1140 ed il 1152 il papa Eugenio III, già monaco dell'Abbazia delle Tre Fontane di Roma, vi introdusse i Cistercensi della linea di Clairvaux, che riedificarono il complesso monastico. Lo steso Papa ne riconsacrò la chiesa il 21 Ottobre 1151. Anche questa abbazia, com'è consuetudine in tutte le costruzioni Cistercensi, possiede nascoste irregolarità e volute asimmetrie, dalle quali tuttavia emerge una segreta armonia d'insieme. Essa però possiede anche un particolare rarissimo, unico in tutte le abbazie cistercensi. Queste, infatti, non spiccano per elaborate decorazioni architettoniche: il loro stile è sempre austero e semplice, allo scopo di favorire il raccoglimento e la preghiera. Ci sorprende, perciò, notare in uno dei capitelli del chiostro, tra le foglie marmoree, la presenza di tre teste scolpite che rappresentano altrettanti distinti personaggi:
Anche questa abbazia, com'è consuetudine in tutte le costruzioni Cistercensi, possiede nascoste irregolarità e volute asimmetrie, dalle quali tuttavia emerge una segreta armonia d'insieme. Essa però possiede anche un particolare rarissimo, unico in tutte le abbazie cistercensi. Queste, infatti, non spiccano per elaborate decorazioni architettoniche: il loro stile è sempre austero e semplice, allo scopo di favorire il raccoglimento e la preghiera. Ci sorprende, perciò, notare in uno dei capitelli del chiostro, tra le foglie marmoree, la presenza di tre teste scolpite che rappresentano altrettanti distinti personaggi:
 Il primo , con la corona, è Federico II di Svevia, colui che fece costruire quello splendido monumento esoterico che è Castel Del Monte, ad Andria (BA). Federico II non era particolarmente indulgente con la Chiesa, ma per i frati Cistercensi fece una eccezione: forse per il loro stretto rapporto con i Templari?
Il primo , con la corona, è Federico II di Svevia, colui che fece costruire quello splendido monumento esoterico che è Castel Del Monte, ad Andria (BA). Federico II non era particolarmente indulgente con la Chiesa, ma per i frati Cistercensi fece una eccezione: forse per il loro stretto rapporto con i Templari?
 Nella seconda immagine vediamo raffigurato a sinistra il cancelliere dell'imperatore, Pier delle Vigne, e qui si apre un altro piccolo mistero! Secondo le cronache ufficiali, l'imperatore fece visita all'abbazia nel 1221 ma storicamente conobbe il suo cancelliere solo nel 1225; com'è possibile? E c'è dell'altro: nel 1222 Federico II era già in odore di scomunica, che poi gli fu tributata ufficialmente nel 1227 da Gregorio IX: com'è possibile che un personaggio così scomodo, sospettato e poi accusato di eresia, frequentasse così benevolmente i frati Cistercensi, che lo onorarono addirittura rappresentandolo in una scultura? Il terzo personaggio, invece, è un enigma. La sua figura barbuta ricorda quella di un altro famoso personaggio, che fu anch'esso ospite nell'abbazia per circa un anno, il predicatore Gioacchino da Fiore (1130-1202). Altri vi vedono semplicemente il ritratto di un frate, forse lo stesso anonimo scultore dei capitelli.
Nella seconda immagine vediamo raffigurato a sinistra il cancelliere dell'imperatore, Pier delle Vigne, e qui si apre un altro piccolo mistero! Secondo le cronache ufficiali, l'imperatore fece visita all'abbazia nel 1221 ma storicamente conobbe il suo cancelliere solo nel 1225; com'è possibile? E c'è dell'altro: nel 1222 Federico II era già in odore di scomunica, che poi gli fu tributata ufficialmente nel 1227 da Gregorio IX: com'è possibile che un personaggio così scomodo, sospettato e poi accusato di eresia, frequentasse così benevolmente i frati Cistercensi, che lo onorarono addirittura rappresentandolo in una scultura? Il terzo personaggio, invece, è un enigma. La sua figura barbuta ricorda quella di un altro famoso personaggio, che fu anch'esso ospite nell'abbazia per circa un anno, il predicatore Gioacchino da Fiore (1130-1202). Altri vi vedono semplicemente il ritratto di un frate, forse lo stesso anonimo scultore dei capitelli.