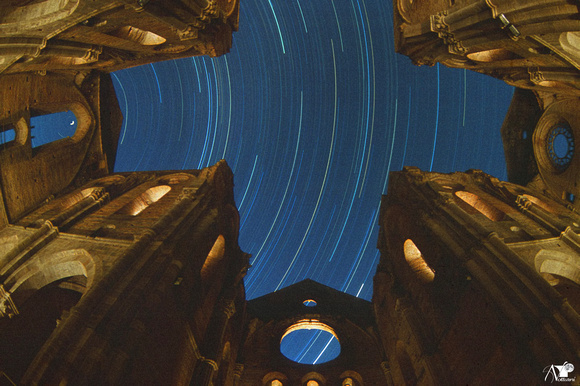Scaltro e ignorante paesanotto, socio di una fortunata associazione letteraria, o geniale autore dei drammi e dei sonetti che resero grande la letteratura inglese elisabettiana?
Sono passati 400 anni dalla sua morte, eppure i misteri che avvolgono William Shakespeare (nato nell'aprile del 1564 a Stratford-upon-Avon e morto il 23 aprile 1616) continuano a infiammare accademici e studiosi.
E il fatto che su di lui esistano solo pochissimi documenti non fa che aumentare la curiosità: il figlio del guantaio di Stratford-upon-Avon fu davvero l’autore di opere immortali come Romeo e Giulietta, il Mercante di Venezia, Otello?
O il Dante d’Inghilterra è solo quella che lo scrittore Henry James definì nel 1903 “la più grande e più riuscita frode che sia mai stata realizzata nei confronti di un mondo paziente”?
La più fedele alle fonti resta la lapidaria biografia del critico letterario settecentesco George Steevens:
“Nacque a Stratford-upon-Avon, si fece là una famiglia, andò a Londra, fece l’attore e lo scrittore, tornò a Stratford, fece testamento e morì”.
Il resto solo ipotesi.
Persino il suo volto resta un mistero: i dipinti e le sculture che lo raffigurano furono realizzati solo dopo la sua morte, da artisti che mai l’avevano conosciuto.
Con una sola eccezione: il busto sul suo monumento funebre, fatto costruire dal genero nella chiesa della Santissima Trinità a Stratford, tra il 1616 e il 1622.
Shakespeare vi appariva accigliato, con barba e baffi all’ingiù, le mani appoggiate su un sacco di grano.
O almeno questo è ciò che si vede nei due disegni che ritraggono l’originale prima che venisse modificato, nel 1720, quando i critici ne avevano fatto il più importante autore della letteratura inglese. Allora il poeta assunse i lineamenti dell’uomo raffinato con il pizzetto che conosciamo: nella mano destra gli fu messa una penna d’oca, nella sinistra un foglio di carta.
Eppure il William dei documenti giudiziari e commerciali, gli unici finora rinvenuti, era molto più simile al rozzo commerciante barbuto: all’Università di Aberystwyth (Galles) si è scoperto che comprava grano durante le carestie per rivenderlo a caro prezzo, che era un usuraio e un evasore fiscale.
Questa mancanza di spirito filantropico è confermata dal suo testamento: nell’atto William non nomina alcun patrimonio librario, né fa accenno alle sue opere.
Si concentra invece sui beni materiali, destinando alla moglie Anne Hathaway “il secondo letto con il mobilio”.
Da qui nascono le speculazioni sul matrimonio infelice di Shakespeare.
Chi vuol difendere l’onore del poeta, ricorda che all’epoca in una casa inglese il primo letto era quello degli ospiti, il secondo quello maritale: l’eredità sarebbe stata quindi un romantico ricordo della loro unione.
Come il sonetto 145, in cui il verso “hate away”, letteralmente “lontano dall’odio”, richiamerebbe il cognome della moglie, cui sarebbe dedicato.
Le malelingue invece notano che quando la coppia si sposò (1582), Anne era già incinta della primogenita Susannah e che, forse, il suo era stato un matrimonio riparatore.
Sappiamo poi che, dopo l’ulteriore nascita di due gemelli (1585), Shakespeare lasciò Stratford: pare lo avesse fatto per sfuggire al processo intentatogli da un signorotto che lo aveva pizzicato mentre cacciava di frodo (o, forse baciava la figlia del guardacaccia) nella sua proprietà.
Comunque siano andate le cose, è da questo momento che si perdono le sue tracce: come trascorse i cosiddetti “anni perduti”, tra il battesimo dei figli e la sua comparsa sulle scene londinesi (1592)?
Le alternative ipotizzate dagli studiosi sono diverse: si aggregò a una delle compagnie teatrali capitate a Stratford intorno al 1587, cominciando così la sua carriera da attore, o impiegò quel tempo per farsi una cultura (sempre ammesso sapesse scrivere, come obiettano alcuni esperti che hanno studiato a fondo la sua firma)? «Più probabilmente, arruolatosi volontariamente o coscritto, dovette attendere la fine delle ostilità tra l’Inghilterra e i Paesi cattolici prima di trovarsi una qualsiasi occupazione a Londra, si presume nel 1589», afferma Corrado Panzieri, studioso di Shakespeare.
Come scrisse nel XVIII secolo uno dei suoi biografi, l’inglese Robert Shiels, William “era un giovane ridotto sul lastrico, che si guadagnava da vivere a Londra prendendosi cura dei cavalli dei gentiluomini che si recavano a teatro”.
Shiels però aggiunge che, colpiti dalla sua parlantina, alcuni attori lo avrebbero raccomandato ai gestori del teatro, dandogli l’occasione di calcare finalmente le scene e di ottenere la fama, “più come scrittore che come attore”.
Nella capitale sarebbe rimasto fino al 1613, ma allora perché non intrattenne con i colleghi letterati scambi epistolari, allora diffusi quanto lo sono ora i post di Facebook? E perché alla sua morte nessuno scrisse un elogio funebre in sua memoria?
Viene proprio da chiederselo: Shakespeare fu davvero il celebrato autore elisabettiano?
Troppi dati non tornano, dicono gli esperti di ieri e di oggi.
E infatti, fin dalla metà dell’Ottocento, gli studiosi hanno pensato di intravvedere fior di papabili autori nascosti dietro quel nome: fra i più famosi il filosofo Francis Bacon, lo scrittore Christopher Marlowe, il colto Edward de Vere conte di Oxford, la contessa Mary Sidney di Pembroke (sorella del poeta Philip) e persino la regina Elisabetta.
Tutti inglesi, ovviamente.
Tranne l’ultimo e attualmente più gettonato candidato: John Florio, letterato di origini italiane, docente a Oxford, con incarichi di prestigio alla corte della regina d’Inghilterra.
«La verità è che certezze non ce ne sono, ma una congerie di nuove informazioni ricavate dallo studio di documenti d’archivio, fa ritenere che chi scrisse quelle opere non fu Shakespeare.
Potrebbe essere stato invece John Florio che, avvalendosi degli appunti, dei racconti e dei testi portati dall’Italia dal padre Michelangelo e grazie alla collaborazione della cerchia di colti parenti e amici e di altri drammaturghi emergenti, avrebbe creato le opere che oggi vengono attribuite al poeta di Stratford», dice Panzieri, cofondatore dell’Istituto di studi floriani di Milano e autore di una biografia sui Florio, in corso di pubblicazione.
Lo confermerebbero le tracce lasciate fra le righe delle tragedie shakespeariane: i neologismi inventati da John per le traduzioni inglesi delle opere italiane; l’ambientazione nelle nostre città e nei luoghi al di fuori dell’Inghilterra frequentati dal padre; le storie romanzate di personaggi che il colto fiorentino aveva conosciuto. Jane Grey, per esempio, regina d’Inghilterra per 9 giorni e allieva di John quando insegnava letteratura italiana presso la famiglia reale, ispirò a Michelangelo un racconto del 1561 da cui il figlio avrebbe tratto Romeo e Giulietta.
Ma se furono i Florio a scrivere le opere, Shakespeare che c’entra? Gli italiani, suggeriscono gli studiosi, volevano mantenere l’anonimato: il padre, uomo di chiesa che aveva abbracciato il riformismo di Lutero, perché temeva ancora le persecuzioni dei cattolici; il figlio, uomo di prestigio a corte, perché all’epoca era considerato sconveniente firmare le opere del teatro popolare.
Ed ecco cosa c’entra William.
«Per venderle e rappresentarle avevano bisogno di un socio come Shakespeare: un tipo volitivo, concreto e intraprendente, già inserito nelle compagnie teatrali», nota l’esperto.
La loro collaborazione però non sarebbe rimasta segreta: il drammaturgo Robert Greene, offeso dalle arie che si dava quel prestanome, denunciò in un libello l’arroganza di “un corvo appena venuto alla ribalta, che (...) benché sia in tutto e per tutto uno Johannes Factotum (per alcuni il soprannome di Florio), si crede il solo Shake-scene (“scuoti-scena”) del paese intero”.
Un segreto di Pulcinella, insomma, forse ancora sepolto fra i 340 volumi e gli scritti dei Florio.
John, infatti, lasciò tutto in eredità al conte William III di Pembroke, ma tuttora gli eredi si rifiutano di aprire le porte della loro biblioteca agli studiosi. Forse, per continuare a difendere il falso mito letterario d’Inghilterra.
Maria Leonarda Leone per Focus 281