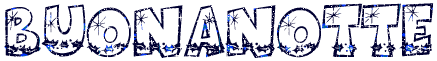
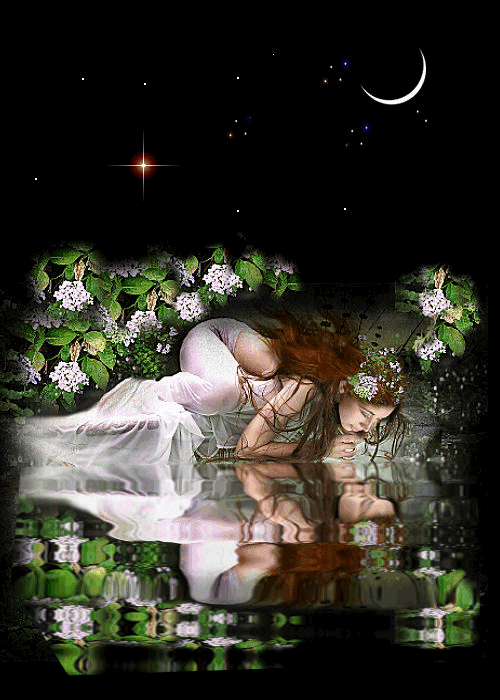

 Quest'opera infatti è composta di quattro disegni dello stesso soggetto, visto sempre più da vicino: un uomo guarda un quadro che in realtà raffigura la galleria d’arte stessa con lui al suo interno.
Quest'opera infatti è composta di quattro disegni dello stesso soggetto, visto sempre più da vicino: un uomo guarda un quadro che in realtà raffigura la galleria d’arte stessa con lui al suo interno.
 La Terra vista dallo spazio è bellissima. Così bella, che una foto del nostro pianeta scattata dall'astronauta dell'Apollo 13 Jim Lovell ispirò all'allora ventunenne Josh Simpson il progetto della sua vita: creare un proprio universo di variopinti pianeti di vetro, con tanto di oceani, continenti, vulcani e nuvole.
Da quando ha imparato a soffiare il vetro al Goddard College, Simpson ha creato migliaia di pianeti grandi e piccoli, e anche spettacolari dischi di vetro che ricordano la corona del Sole, Saturno e i suoi anelli. I pianeti più grandi, del diametro di 30 centimetri per più di 20 chili di peso, oggi si trovano nelle collezioni permanenti del Museum of Fine Art di Boston, del Corning Museum of Glass, della Art Gallery di Yale e in molte altre gallerie e istituzioni.
La Terra vista dallo spazio è bellissima. Così bella, che una foto del nostro pianeta scattata dall'astronauta dell'Apollo 13 Jim Lovell ispirò all'allora ventunenne Josh Simpson il progetto della sua vita: creare un proprio universo di variopinti pianeti di vetro, con tanto di oceani, continenti, vulcani e nuvole.
Da quando ha imparato a soffiare il vetro al Goddard College, Simpson ha creato migliaia di pianeti grandi e piccoli, e anche spettacolari dischi di vetro che ricordano la corona del Sole, Saturno e i suoi anelli. I pianeti più grandi, del diametro di 30 centimetri per più di 20 chili di peso, oggi si trovano nelle collezioni permanenti del Museum of Fine Art di Boston, del Corning Museum of Glass, della Art Gallery di Yale e in molte altre gallerie e istituzioni.
 Simpson dice che la spinta gli "viene direttamente dal materiale. Il vetro è una miscela chimica di sabbia e ossidi di metallo combinati a temperatura altissima" Il risultato, spiega, "è un materiale che scorre e cola come il miele. Quando è caldo, il vetro è vivo. Si muove inesorabilmente ma con grazia, in risposta alla gravità e alla forza centrifuga. Ha una luce, un calore trascendente che lo rende uno dei più frustranti materiali con cui lavorare, e allo stesso tempo, uno di quelli che danno più soddisfazione."
Simpson dice che la spinta gli "viene direttamente dal materiale. Il vetro è una miscela chimica di sabbia e ossidi di metallo combinati a temperatura altissima" Il risultato, spiega, "è un materiale che scorre e cola come il miele. Quando è caldo, il vetro è vivo. Si muove inesorabilmente ma con grazia, in risposta alla gravità e alla forza centrifuga. Ha una luce, un calore trascendente che lo rende uno dei più frustranti materiali con cui lavorare, e allo stesso tempo, uno di quelli che danno più soddisfazione."
 Simpson non usa a caso termini come gravità e forza centrifuga. Si è specializzato nella scienza del vetro a un livello incredibile di dettaglio. I particolari dei suoi pianeti - le strutture inglobate nella sfera esterna - sono a loro volta composti da molti pezzi di vetro colorati in forno in condizioni ben precise. "Diverse sfumature di blu vengono dal mescolare il vetro con l'argento, in stati di ossidazione diversi" spiega.
Combinando più oggetti colorati diversi nel globo più grande, la scienza diventa ancora più importante. "Aggiungere cobalto, per esempio, cambia il coefficiente di espansione del vetro." Altri additivi creano parti con coefficienti diversi. "Quindi, se uso 50 o più colori in un pianeta, mi serve un procedimento molto preciso, o può esplodere tutto."
Simpson non usa a caso termini come gravità e forza centrifuga. Si è specializzato nella scienza del vetro a un livello incredibile di dettaglio. I particolari dei suoi pianeti - le strutture inglobate nella sfera esterna - sono a loro volta composti da molti pezzi di vetro colorati in forno in condizioni ben precise. "Diverse sfumature di blu vengono dal mescolare il vetro con l'argento, in stati di ossidazione diversi" spiega.
Combinando più oggetti colorati diversi nel globo più grande, la scienza diventa ancora più importante. "Aggiungere cobalto, per esempio, cambia il coefficiente di espansione del vetro." Altri additivi creano parti con coefficienti diversi. "Quindi, se uso 50 o più colori in un pianeta, mi serve un procedimento molto preciso, o può esplodere tutto."
 La chimica del vetro affascina Simpson al punto da aver trovato il modo di creare meteoriti artificiali. Anni fa, un amico gli regalò una tektite, una meteorite vetrosa composta di silicati e ossidi di metallo. Un altro amico ne analizzò lo spettro, e Simpson creò nel suo forno le condizioni che per fare un tipo simile di roccia. "Mi accorsi che la composizione del meteorite non era tanto complicata", racconta, così sciolse e mescolò i materiali seguendo la formula spettrale. Da Simpson allora ha creato molte altre meteoriti artificiali, trasformandole in oggetti d'arte con intarsi in vetro colorato.
La chimica del vetro affascina Simpson al punto da aver trovato il modo di creare meteoriti artificiali. Anni fa, un amico gli regalò una tektite, una meteorite vetrosa composta di silicati e ossidi di metallo. Un altro amico ne analizzò lo spettro, e Simpson creò nel suo forno le condizioni che per fare un tipo simile di roccia. "Mi accorsi che la composizione del meteorite non era tanto complicata", racconta, così sciolse e mescolò i materiali seguendo la formula spettrale. Da Simpson allora ha creato molte altre meteoriti artificiali, trasformandole in oggetti d'arte con intarsi in vetro colorato.
 Negli ultimi anni sono stati colpiti da questa “piaga d’Egitto”: Cina, Stati Uniti, Africa e, nel novembre 2008, sei chilometri di campagna australiana.
Negli ultimi anni sono stati colpiti da questa “piaga d’Egitto”: Cina, Stati Uniti, Africa e, nel novembre 2008, sei chilometri di campagna australiana. Gabrielle-Emilie de Breteuil era sposata con il marchese di Chatelet, dal quale ebbe tre figli. Mentre il marito percorreva le tappe di una prestigiosa carriera militare, gli interessi della moglie andavano agli studi scientifici, soprattutto alla matematica e alla fisica: cosa piuttosto insolita per una donna del Settecento. Le sue inclinazioni la misero in rapporto con Voltaire: una conoscenza stimolante per le sue ricerche, che sfociò nella traduzione in francese dei Principia di Isaac Newton (1687), l’opera in cui sono esposti i più celebri assiomi sulla meccanica newtoniana.
Gabrielle-Emilie de Breteuil era sposata con il marchese di Chatelet, dal quale ebbe tre figli. Mentre il marito percorreva le tappe di una prestigiosa carriera militare, gli interessi della moglie andavano agli studi scientifici, soprattutto alla matematica e alla fisica: cosa piuttosto insolita per una donna del Settecento. Le sue inclinazioni la misero in rapporto con Voltaire: una conoscenza stimolante per le sue ricerche, che sfociò nella traduzione in francese dei Principia di Isaac Newton (1687), l’opera in cui sono esposti i più celebri assiomi sulla meccanica newtoniana.
 Voltaire era considerato un uomo freddo, cinico e calcolatore, alieno alle passioni romantiche e implacabile fustigatore della mentalità del suo tempo. Fervido fautore della ragione, credeva nella forza dell’intelletto e nell’umanità e come nessuno altro diede la sua impronta all’età dell’illuminismo. Lo scrittore pagò con frequenti soggiorni in galera la causticità delle sue opere. Tra queste vi furono le “Lettere filosofiche” (note anche come “Lettere sugli inglesi”) dove, descrivendo in apparenza l’isola d’oltremanica, lanciava feroci strali alla situazione francese; era fatale che il libro finisse sul tavolo del giudice. Per sfuggire a un’altra condanna Voltaire si rifugiò a Cirey, che sorgeva sul territorio del ducato di Lorena, allora indipendente dalla Francia.
Voltaire era considerato un uomo freddo, cinico e calcolatore, alieno alle passioni romantiche e implacabile fustigatore della mentalità del suo tempo. Fervido fautore della ragione, credeva nella forza dell’intelletto e nell’umanità e come nessuno altro diede la sua impronta all’età dell’illuminismo. Lo scrittore pagò con frequenti soggiorni in galera la causticità delle sue opere. Tra queste vi furono le “Lettere filosofiche” (note anche come “Lettere sugli inglesi”) dove, descrivendo in apparenza l’isola d’oltremanica, lanciava feroci strali alla situazione francese; era fatale che il libro finisse sul tavolo del giudice. Per sfuggire a un’altra condanna Voltaire si rifugiò a Cirey, che sorgeva sul territorio del ducato di Lorena, allora indipendente dalla Francia.
 La dimora di campagna dei coniugi du Chatelet fu rinnovata e sontuosamente rifinita da Voltaire stesso, a proprie spese. Con l’amica Emilie, il filosofo mise a punto un rigoroso piano di studi da attuare nella villa, con orari esattamente definiti per l’attività intellettuale, le conservazioni, i pasti, il teatro e la musica. L’insieme non era forse architettonicamente armonioso: troppo irregolare, con tracce di parecchi stili nelle facciate; ma era, tuttavia, contornato da una campagna deliziosa, propizia alle tranquille passeggiate, ai discorsi filosofici, all’abbandono nella pace della natura. Tanto che Cirey divenne una delle più celebri residenze di campagna del Settecento francese.
La dimora di campagna dei coniugi du Chatelet fu rinnovata e sontuosamente rifinita da Voltaire stesso, a proprie spese. Con l’amica Emilie, il filosofo mise a punto un rigoroso piano di studi da attuare nella villa, con orari esattamente definiti per l’attività intellettuale, le conservazioni, i pasti, il teatro e la musica. L’insieme non era forse architettonicamente armonioso: troppo irregolare, con tracce di parecchi stili nelle facciate; ma era, tuttavia, contornato da una campagna deliziosa, propizia alle tranquille passeggiate, ai discorsi filosofici, all’abbandono nella pace della natura. Tanto che Cirey divenne una delle più celebri residenze di campagna del Settecento francese.
 Non è mai stata chiarita fino in fondo la reale natura dei rapporti fra Voltaire e Madame du Chatelet. Alcuni descrivono la marchesa come una donna vanitosa e immorale, altri vedono nella sua vita con il filosofo nel castello di Cirey una specie di prolungata luna di miele. I due erano amanti che fingevano di dedicarsi a un lavoro in comune per placare i dubbi del marito di Emilie, oppure questi sapeva fin dall’inizio del loro legame e lo tollerava, magari riservandosi a sua volta qualche avventura galante? Secondo alcuni storici Voltaire avrebbe confidato al re di Prussia Federico II il Grande che le cose stavano addirittura a rovescio: da una iniziale storia d’amore era nata una relazione spirituale, del tutto platonica. In ogni caso, una cosa è certa: Voltaire non provò per nessun’altra persona un sentimento cosi profondo. Nemmeno quando, nel 1748, Emilie si innamorò del marchese Saint-Lambert e ne restò incinta Voltaire ruppe con lei. Ed è certo che la morte della marchesa di Chatelet lo portò quasi alla disperazione. Questa morte fu crudele e improvvisa. Nel 1749 Madame du Chatelet mise al mondo una bambina: un parto facile, iniziato, per non smentire la fama della puerpera, mentre stava approfondendo alcune questioni di matematica. Eppure pochi giorni dopo Emilie morì, seguita quasi subito dalla figlia.
Non è mai stata chiarita fino in fondo la reale natura dei rapporti fra Voltaire e Madame du Chatelet. Alcuni descrivono la marchesa come una donna vanitosa e immorale, altri vedono nella sua vita con il filosofo nel castello di Cirey una specie di prolungata luna di miele. I due erano amanti che fingevano di dedicarsi a un lavoro in comune per placare i dubbi del marito di Emilie, oppure questi sapeva fin dall’inizio del loro legame e lo tollerava, magari riservandosi a sua volta qualche avventura galante? Secondo alcuni storici Voltaire avrebbe confidato al re di Prussia Federico II il Grande che le cose stavano addirittura a rovescio: da una iniziale storia d’amore era nata una relazione spirituale, del tutto platonica. In ogni caso, una cosa è certa: Voltaire non provò per nessun’altra persona un sentimento cosi profondo. Nemmeno quando, nel 1748, Emilie si innamorò del marchese Saint-Lambert e ne restò incinta Voltaire ruppe con lei. Ed è certo che la morte della marchesa di Chatelet lo portò quasi alla disperazione. Questa morte fu crudele e improvvisa. Nel 1749 Madame du Chatelet mise al mondo una bambina: un parto facile, iniziato, per non smentire la fama della puerpera, mentre stava approfondendo alcune questioni di matematica. Eppure pochi giorni dopo Emilie morì, seguita quasi subito dalla figlia.

 La datazione di una serie di frammenti di vasellame trovati nel sito cinese della grotta di Xianrendong, nella provincia di Jiangxi, porta a spostare indietro nel tempo di almeno 2000-3000 anni l’introduzione di questa tecnologia fondamentale per la storia dell’umanità.
La datazione di una serie di frammenti di vasellame trovati nel sito cinese della grotta di Xianrendong, nella provincia di Jiangxi, porta a spostare indietro nel tempo di almeno 2000-3000 anni l’introduzione di questa tecnologia fondamentale per la storia dell’umanità. La scoperta e la datazione delle ceramiche cinesi rappresenta quindi un importante punto a favore di questa prospettiva. La testimonianza di questo complesso di tecnologie già nel corso dell'ultimo massimo glaciale, in anticipo di almeno 10.000 anni rispetto all'agricoltura, suggerisce infatti che l’ampliamento della dieta umana, con l’introduzione di alimenti difficili da lavorare e da digerire (come il miglio e il riso in Cina) siano stati un momento centrale per gli eventi successivi che avrebbero portato alla domesticazione delle piante selvatiche, all’introduzione dell’agricoltura e infine a società più complesse.
La scoperta e la datazione delle ceramiche cinesi rappresenta quindi un importante punto a favore di questa prospettiva. La testimonianza di questo complesso di tecnologie già nel corso dell'ultimo massimo glaciale, in anticipo di almeno 10.000 anni rispetto all'agricoltura, suggerisce infatti che l’ampliamento della dieta umana, con l’introduzione di alimenti difficili da lavorare e da digerire (come il miglio e il riso in Cina) siano stati un momento centrale per gli eventi successivi che avrebbero portato alla domesticazione delle piante selvatiche, all’introduzione dell’agricoltura e infine a società più complesse.