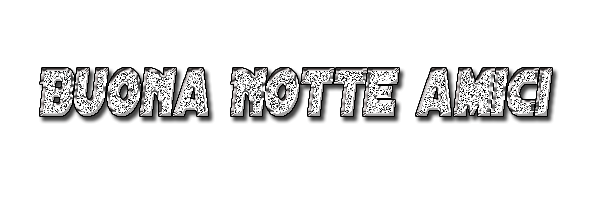

Coloro che sognano di giorno
sanno molte cose che sfuggono
a chi sogna soltanto di notte.
(Edgar Allan Poe)
 (Express-news.it) Nella savana della Namibia, nel sud Africa, esistono delle misteriose chiazze glabre di vegetazione, appaiono improvvisamente e scompaiono dopo anni, sempre improvvisamente.
(Express-news.it) Nella savana della Namibia, nel sud Africa, esistono delle misteriose chiazze glabre di vegetazione, appaiono improvvisamente e scompaiono dopo anni, sempre improvvisamente. Ci sono pochi ricercatori che hanno studiato i cerchi delle fate.
Ci sono pochi ricercatori che hanno studiato i cerchi delle fate. La ricerca, non invasiva, cioè condotta attraverso un’indagine archeologica senza scavi, è stata effettuata l’estate scorsa con strumentazioni quali georadar, radiometri e magnetometri in terreni privati presso la frazione di Tezze, in località Valbruna, ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Visonà venne a conoscenza della possibile presenza di un antico insediamento da un agricoltore di Valbruna. Quest’ultimo, Battista Carlotto, mentre lavorava la sua terra aveva scoperto reperti antichi quali ceramiche, mosaici e vetri attribuibili all’epoca imperiale romana.
Visonà cominciò così a cercare testimonianze storiche relative a quella zona. E nella biblioteca Bertoliana di Vicenza trovò manoscritti che confermarono il suo sospetto. In quei manoscritti infatti si legge che nel tardo XVIII secolo testimoni avevano visto i resti della città romana. Così non volendo operare con metodi invasivi nei campi di Carlotto, Visonà ha dovuto escogitare un modo per trovare le prove dell’esistenza di quell’insediamento. In suo aiuto è giunto il collega George Crothers, professore associato di antropologia nel Regno Unito: «George aveva le basi per fare questo tipo di ricerca», dice Visonà, «con tecniche geofisiche e gli strumenti per scoprire le caratteristiche architettoniche nascoste di questo sito».
Crothers spiega: «Il sito non era stato scavato, e le tecniche geofisiche sono un modo per guardare sotto terra senza disturbare il terreno». Il team ha utilizzato un magnetometro e un radar per indagare il suolo. Il magnetometro misura le variazioni nell’intensità magnetica del terreno e può rilevare le caratteristiche degli oggetti seppelliti. Il radar emette onde sottoterra che poi vengono riflesse. È stato così possibile creare una mappa di ciò che c’è sotto la superficie.
In primo luogo la squadra ha confermato la presenza di una strada e pareti che indicano la presenza di edifici romani. A giudicare dai materiali trovati in superficie e durante i lavori agricoli, l’insediamento poteva essere esistito per più di 400 anni, dal I secolo a. C. al III-IV secolo d. C. Le informazioni del manoscritto indicarono che era molto vasto. «Riguardano un lungo periodo, alcune sono molto dettagliate, di testimoni oculari che hanno visto la città romana in due diverse occasioni», spiga Visonà, «quando venne in parte alla luce durante le inondazioni del fiume Guà. Ma erano informazioni sparse e mai davvero considerate dagli scienziati».
La ricerca, non invasiva, cioè condotta attraverso un’indagine archeologica senza scavi, è stata effettuata l’estate scorsa con strumentazioni quali georadar, radiometri e magnetometri in terreni privati presso la frazione di Tezze, in località Valbruna, ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Visonà venne a conoscenza della possibile presenza di un antico insediamento da un agricoltore di Valbruna. Quest’ultimo, Battista Carlotto, mentre lavorava la sua terra aveva scoperto reperti antichi quali ceramiche, mosaici e vetri attribuibili all’epoca imperiale romana.
Visonà cominciò così a cercare testimonianze storiche relative a quella zona. E nella biblioteca Bertoliana di Vicenza trovò manoscritti che confermarono il suo sospetto. In quei manoscritti infatti si legge che nel tardo XVIII secolo testimoni avevano visto i resti della città romana. Così non volendo operare con metodi invasivi nei campi di Carlotto, Visonà ha dovuto escogitare un modo per trovare le prove dell’esistenza di quell’insediamento. In suo aiuto è giunto il collega George Crothers, professore associato di antropologia nel Regno Unito: «George aveva le basi per fare questo tipo di ricerca», dice Visonà, «con tecniche geofisiche e gli strumenti per scoprire le caratteristiche architettoniche nascoste di questo sito».
Crothers spiega: «Il sito non era stato scavato, e le tecniche geofisiche sono un modo per guardare sotto terra senza disturbare il terreno». Il team ha utilizzato un magnetometro e un radar per indagare il suolo. Il magnetometro misura le variazioni nell’intensità magnetica del terreno e può rilevare le caratteristiche degli oggetti seppelliti. Il radar emette onde sottoterra che poi vengono riflesse. È stato così possibile creare una mappa di ciò che c’è sotto la superficie.
In primo luogo la squadra ha confermato la presenza di una strada e pareti che indicano la presenza di edifici romani. A giudicare dai materiali trovati in superficie e durante i lavori agricoli, l’insediamento poteva essere esistito per più di 400 anni, dal I secolo a. C. al III-IV secolo d. C. Le informazioni del manoscritto indicarono che era molto vasto. «Riguardano un lungo periodo, alcune sono molto dettagliate, di testimoni oculari che hanno visto la città romana in due diverse occasioni», spiga Visonà, «quando venne in parte alla luce durante le inondazioni del fiume Guà. Ma erano informazioni sparse e mai davvero considerate dagli scienziati».
 Un nonno Neandertal ce lo abbiamo avuto tutti.
Un nonno Neandertal ce lo abbiamo avuto tutti. La questione è annosa ed è da un bel po’ che gli antropologi ne discutono.
La questione è annosa ed è da un bel po’ che gli antropologi ne discutono. Elegante e fastoso, Chenonceaux è legato alle grandi dame della corte francese.
Elegante e fastoso, Chenonceaux è legato alle grandi dame della corte francese.  ‘Le chàteau des Dames’, il castello delle dame, venne eretto nel 1513-21 per una nobildonna dell’epoca, Catherine Briçonnet. Dal 1547 al 1559 fu una delle residenze preferite dell’amante di Enrico II, Diana di Poiters: che, secondo le dicerie popolari, era solita, la mattina, fare il bagno nuda nel fiume. Dopo la morte di Enrico, Diana fu costretta a lasciare la tenuta a Caterina de’ Medici, vedova del re, che organizzò nel castello e nel parco ricevimenti spettacolari e travolgenti, allietati da fuochi d’artificio. La sola festa allestita per Francesco II e sua moglie, la regina scozzese Maria Stuarda, sarebbe costata una somma da capogiro.
‘Le chàteau des Dames’, il castello delle dame, venne eretto nel 1513-21 per una nobildonna dell’epoca, Catherine Briçonnet. Dal 1547 al 1559 fu una delle residenze preferite dell’amante di Enrico II, Diana di Poiters: che, secondo le dicerie popolari, era solita, la mattina, fare il bagno nuda nel fiume. Dopo la morte di Enrico, Diana fu costretta a lasciare la tenuta a Caterina de’ Medici, vedova del re, che organizzò nel castello e nel parco ricevimenti spettacolari e travolgenti, allietati da fuochi d’artificio. La sola festa allestita per Francesco II e sua moglie, la regina scozzese Maria Stuarda, sarebbe costata una somma da capogiro.
 Gran parte del fascino dei castelli rinascimentali francesi deriva dall’abile uso dell’acqua come elemento architettonico: quasi sempre si tratta di costruzioni circondate, o addirittura affioranti dalle acque, cosi da rispecchiarsi, con scenografici e romantici effetti. Da un punto di vista funzionale, l’acqua era uno strumento di difesa, o quanto meno di selezione. I castelli non avevano più apparati bellici e le torrette che li ornavano non avevano funzioni militari ma solo decorative: l’acqua costituiva una buona barriera contro ladri, banditi o visitatori indesiderati. Tuttavia, da un punto di vista più generale, era un elemento naturale che dava dolcezza e risalto all’architettura, conferendole un aspetto magico.
Gran parte del fascino dei castelli rinascimentali francesi deriva dall’abile uso dell’acqua come elemento architettonico: quasi sempre si tratta di costruzioni circondate, o addirittura affioranti dalle acque, cosi da rispecchiarsi, con scenografici e romantici effetti. Da un punto di vista funzionale, l’acqua era uno strumento di difesa, o quanto meno di selezione. I castelli non avevano più apparati bellici e le torrette che li ornavano non avevano funzioni militari ma solo decorative: l’acqua costituiva una buona barriera contro ladri, banditi o visitatori indesiderati. Tuttavia, da un punto di vista più generale, era un elemento naturale che dava dolcezza e risalto all’architettura, conferendole un aspetto magico.
 Tra le tante novità giunte dall’Italia una di quelle destinate ai massimi fasti fu la ‘galleria’. Fino ad allora, le stanze dei castelli e dei palazzi non erano – per usare termini attuali –disimpegnate: al contrario, erano accostate tra di loro, e la porta di una stanza si apriva direttamente sulla stanza vicina. Con quanta intimità e con quale agio per gli abitanti è facile capire. Nel corso del Rinascimento si diffuse in Italia l’abitudine di allineare le stanze lungo un corridoio di disimpegno, in modo che per andare da una stanza a un’altra si potesse usare tale spazio, senza disturbare gli occupanti delle stanze intermedie. Questo corridoio portava il nome di ‘galleria’ e fu per lungo tempo, aperto sul lato esterno, finché nel corso del Seicento, con il progredire della tecnica vetraria, si prese l’abitudine di chiuderlo con ampi finestroni. Poiché questo nuovo locale era il primo che si incontrava nella casa, e godeva di abbondante luce, divenne consueto esporvi i pezzi pregiati della casa: statue, quadri, arazzi, mobili. Cosi il termine galleria acquisto il significato di raccolta d’arte che mantiene ancora. A Chenonceaux si ha uno dei primi esempi di galleria di questo tipo: un lungo ambiente senza più stanze da disimpegnare, che ha in sé la sua giustificazione, e poteva essere usato per esporre opere d’arte, passeggiare o ammirare il panorama del fiume.
Tra le tante novità giunte dall’Italia una di quelle destinate ai massimi fasti fu la ‘galleria’. Fino ad allora, le stanze dei castelli e dei palazzi non erano – per usare termini attuali –disimpegnate: al contrario, erano accostate tra di loro, e la porta di una stanza si apriva direttamente sulla stanza vicina. Con quanta intimità e con quale agio per gli abitanti è facile capire. Nel corso del Rinascimento si diffuse in Italia l’abitudine di allineare le stanze lungo un corridoio di disimpegno, in modo che per andare da una stanza a un’altra si potesse usare tale spazio, senza disturbare gli occupanti delle stanze intermedie. Questo corridoio portava il nome di ‘galleria’ e fu per lungo tempo, aperto sul lato esterno, finché nel corso del Seicento, con il progredire della tecnica vetraria, si prese l’abitudine di chiuderlo con ampi finestroni. Poiché questo nuovo locale era il primo che si incontrava nella casa, e godeva di abbondante luce, divenne consueto esporvi i pezzi pregiati della casa: statue, quadri, arazzi, mobili. Cosi il termine galleria acquisto il significato di raccolta d’arte che mantiene ancora. A Chenonceaux si ha uno dei primi esempi di galleria di questo tipo: un lungo ambiente senza più stanze da disimpegnare, che ha in sé la sua giustificazione, e poteva essere usato per esporre opere d’arte, passeggiare o ammirare il panorama del fiume.
 Le grandi dimore, soprattutto se prestigiose, non erano all’epoca solo esempi di architettura ma anche, grazie al loro valore aggiunto, manifestazioni di gusto e prestigio, teatri per la vita aristocratica, strumenti di potere assai ambiti, intorno a cui si consumavano spesso segrete quanto spietate lotte. Alla fine del Cinquecento Chenonceaux fu la posta in gioco di una lotta serrata e alquanto complicata. Alla sua morte, nel 1589, Caterina de’ Medici aveva lasciato in eredità alla nuora Luisa di Lorena, moglie di Enrico III, la proprietà del castello. Purtroppo, il sovrano fu assassinato lo stesso anno, e Luisa apprese proprio a Chenonceaux la funesta notizia che la privava dell’adorato marito. Decise quindi di ritirarsi in stetta vedovanza nel castello, scomparendo dalla corte. L’amante del nuovo re, Gabrielle d’Estrées, bramava di impossessarsi della splendida proprietà, ed esercitò tutto il suo potere per riuscirci. Fu organizzata allora una complicatissima serie di scambi, secondo quale Luisa cedeva il castello alla nipote, Francesca di Lorena, di sei anni. Questa, a sua volta, veniva promessa in sposa al figlio naturale di Enrico IV, César de Vendòme, di quattro anni. In tal modo Gabrielle d’Estrées poteva avere il castello, nominalmente del figlio. Luisa fu invece indennizzata con l’usufrutto a vita del feudo d’origine del re, il Borbonese, dove morì nel 1601. Chenonceaux passò cosi ai Vendòme, cui rimase fino al 1720.
Le grandi dimore, soprattutto se prestigiose, non erano all’epoca solo esempi di architettura ma anche, grazie al loro valore aggiunto, manifestazioni di gusto e prestigio, teatri per la vita aristocratica, strumenti di potere assai ambiti, intorno a cui si consumavano spesso segrete quanto spietate lotte. Alla fine del Cinquecento Chenonceaux fu la posta in gioco di una lotta serrata e alquanto complicata. Alla sua morte, nel 1589, Caterina de’ Medici aveva lasciato in eredità alla nuora Luisa di Lorena, moglie di Enrico III, la proprietà del castello. Purtroppo, il sovrano fu assassinato lo stesso anno, e Luisa apprese proprio a Chenonceaux la funesta notizia che la privava dell’adorato marito. Decise quindi di ritirarsi in stetta vedovanza nel castello, scomparendo dalla corte. L’amante del nuovo re, Gabrielle d’Estrées, bramava di impossessarsi della splendida proprietà, ed esercitò tutto il suo potere per riuscirci. Fu organizzata allora una complicatissima serie di scambi, secondo quale Luisa cedeva il castello alla nipote, Francesca di Lorena, di sei anni. Questa, a sua volta, veniva promessa in sposa al figlio naturale di Enrico IV, César de Vendòme, di quattro anni. In tal modo Gabrielle d’Estrées poteva avere il castello, nominalmente del figlio. Luisa fu invece indennizzata con l’usufrutto a vita del feudo d’origine del re, il Borbonese, dove morì nel 1601. Chenonceaux passò cosi ai Vendòme, cui rimase fino al 1720.
 Il caffè è considerato un bene di prima necessità.Si stima che ogni anno un italiano ne consumi quasi sei kilogrammi e il suo commercio internazionale è secondo solo a quello del petrolio.
Il caffè è considerato un bene di prima necessità.Si stima che ogni anno un italiano ne consumi quasi sei kilogrammi e il suo commercio internazionale è secondo solo a quello del petrolio.